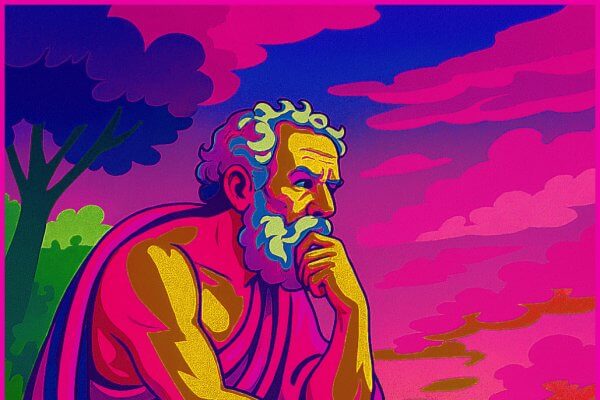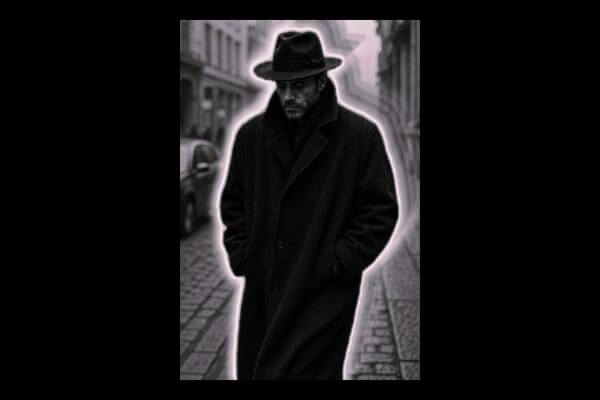ABBOZZO FRAMMENTARIO DI UNA FENOMENOLOGIA DELL’ESISTENZA RADICALE (PARTE II)

Il primo grande filosofo ad aver intuito tutto ciò, in modo chiaro e distinto, è stato senz’altro Cartesio. Dopo aver esercitato fino in fondo il proprio dubbio iperbolico, Cartesio si rende conto che possiamo essere assolutamente certi solo di ciò che pensiamo qui e adesso, di ciò che ci si manifesta, nella sua semplice presenza, sotto forma di idee. Che a tali idee possa corrispondere effettivamente qualcosa di reale nel mondo esteso che presumiamo trovarsi fuori di noi, è qualcosa che non possiamo in alcun modo dire. Possiamo essere del tutto certi dei nostri stati di coscienza e del loro contenuto rappresentativo, mentre non possiamo esserlo affatto per quanto riguarda la presunta realtà, esterna ed estesa, di cui tali stati di coscienza sarebbero solo ed esclusivamente rappresentazione mentale. Il Cogito cartesiano ci assicura che tutto ciò che percepiamo qui e adesso, nel suo semplice presentarsi e manifestarsi alla nostra coscienza, è l’essere più certo e sicuro che ci possa essere. Perfino lo scettico più agguerrito è razionalmente costretto ad ammetterlo. Ergo, l’essere si identifica totalmente con ciò che percepiamo e pensiamo qui e adesso, Hic et Nunc, nel suo semplice presentarsi e manifestarsi alla nostra coscienza.
Questa è la verità a cui giunge il filosofo Cartesio. Purtroppo, lo scienziato Cartesio non poteva accettare una posizione ontologica tanto radicale. La fisica ha bisogno di presupporre e affermare l’esistenza della realtà esterna ed estesa, in quanto disciplina scientifica che ne studia le caratteristiche sia dinamiche sia statiche. Per questo motivo, il filosofo Cartesio finirà per farsi traviare dallo scienziato Cartesio. Per dimostrare l’esistenza della realtà esterna ed estesa, l’esistenza della res extensa, sarà costretto a dimostrare l’esistenza di Dio, ovvero di un ente presunto che, come abbiamo già visto, non saremo mai in grado di percepire qui e adesso, nel suo semplice presentarsi e manifestarsi alla nostra coscienza, e lo farà attraverso tre prove che, per quanto eleganti e apparentemente convincenti nella loro argomentazione di chiara derivazione scolastica, non dimostrano, in verità, proprio un bel nulla. Dimostrata (diciamo così) l’esistenza di Dio, Cartesio non può non concludere che tale Dio, in quanto infinitamente buono (proprietà divina, questa, che Cartesio non dimostra da nessuna parte), non può affatto ingannarci riguardo all’esistenza del mondo esterno ed esteso, per il semplice motivo che, se lo facesse, non sarebbe più un Dio infinitamente buono, ma solo un ingannevole e capriccioso genio maligno. Cartesio finisce così per ammettere che, dietro e oltre all’essere che si manifesta qui e adesso nella nostra coscienza, esistono sia una realtà esterna ed estesa, la res extensa, sia, addirittura, una realtà divina, ricadendo in questo modo nell’errore capitale della metafisica occidentale.
Occorre comunque riconoscere un piccolo merito alla metafisica cartesiana. Per Cartesio, l’essere in quanto semplice presenza, che si manifesta qui e ora nella coscienza, non è inteso come un’effimera apparenza, frutto di una visione superficiale della realtà, la quale nasconde il “vero” essere a cui solo una visione profonda delle cose può accedere, ma viene inteso come quell’essere primariamente veritiero su cui poi, in un secondo momento, costruisce i suoi aerei castelli metafisici (Dio e la realtà esterna) a cui attribuisce erroneamente, come c’era da aspettarselo, la piena e totale dignità di essere.
Per questo motivo, Cartesio, pur avendo preso criticamente una certa distanza dalla tradizione filosofica occidentale, non può non essere che collocato ancora in essa, risultando alla fine uno dei più importanti e conclamati rappresentanti di tale tradizione. Se solo si fosse fermato al suo celeberrimo Cogito, Cartesio sarebbe stato, senza alcuna ombra di dubbio, il primo pensatore a filosofare davvero col martello, e a liberarci da tutti i “mondi dietro il mondo” che infestano, e hanno sempre mefiticamente infestato, l’intera storia della metafisica occidentale.
Abbiamo appena visto come l’essere appaia e si manifesti qui e ora, nella sua semplice presenza, alla coscienza. Ma cos’è la coscienza? In che modo intenderla? La coscienza può, e deve, essere definita solo in relazione all’essere che appare manifestandosi qui e ora nella sua semplice presenza. La coscienza, infatti, è il manifestarsi stesso di tale essere. La definizione qui data di coscienza potrebbe sembrare un inutile e insensato accartocciamento tautologico, ma non è così. La coscienza è il “luogo”, lo “spazio”, in cui l’essere si manifesta. Il virgolettato è giustificato dal fatto che la coscienza non è propriamente né un luogo né uno spazio, ma il manifestarsi e l’apparire stesso dell’essere qui e ora nella sua semplice presenza.
Occorre innanzitutto precisare che qui si parla della mia coscienza, sempre e solo della mia coscienza. Il discorso non vale per tutte le coscienze che presumo alberghino negli altri esseri umani. La coscienza altrui non mi si manifesta qui e adesso, nella sua semplice presenza. Quando ho di fronte un altro essere umano, vedo degli occhi che mi osservano, una bocca che mi parla, un corpo che si muove in un certo qual modo. Non vedo, non percepisco, nessuna coscienza nell’altro essere umano. La coscienza altrui non mi si manifesta nella sua semplice presenza, qui e ora. Per questo motivo, non fa parte dell’essere. Solo ciò che si manifesta qui e adesso, nella sua semplice presenza, esiste per davvero. Ergo, la coscienza altrui non esiste.
Una volta chiarito che quando si parla di coscienza si parla sempre e soltanto della mia coscienza, dobbiamo adesso definire quale sia la natura di tale coscienza. La coscienza non è qualcosa di spirituale, un’entità non corporea o extracorporea in cui l’essere si manifesta e appare nella sua pura idealità. La coscienza, come insegna Merleau-Ponty, è sempre coscienza incarnata. Tra le tante cose che posso percepire e sentire (ovvero: vedere, toccare, ascoltare, ecc…), il mio corpo ha senz’altro uno status del tutto particolare, uno status particolare ben descritto della felice intuizione filosofica di Schopenhauer. Non mi limito a percepire e a sentire il mio corpo dall’esterno, come avviene per tutto il resto, ma lo percepisco e lo sento anche dall’interno. Anzi, io posso percepire e sentire tutto il resto proprio perché ho un corpo dotato di quegli organi di senso che permettono sia la percezione sia la sensazione. La connessione tra coscienza e corpo è quindi, concettualmente e fattivamente, necessaria. La coscienza è sempre, necessariamente, coscienza incarnata.
Connessione, tuttavia, non significa affatto identità. Il corpo, infatti, quando viene percepito dall’esterno, si presenta alla coscienza qui e adesso, nella sua semplice presenza, in quanto fenomeno distinto dalla coscienza. Ciò non toglie, tuttavia, che la coscienza si presenti sempre connessa al corpo, come coscienza incarnata.
In quanto coscienza incarnata, la coscienza “sente” il proprio corpo, e in questo sentire si fa tutt’uno con esso. Cosa “sente”, la coscienza, del corpo in cui si trova incarnata? La prima cosa che sente è il dolore. La coscienza percepisce il proprio corpo dall’interno come un complesso fascio di impulsi e di pulsioni che la spingono verso determinate mete. La fame e la sete la spingono a desiderare il cibo necessario per la sopravvivenza del proprio corpo, mentre l’impulso sessuale la spinge a desiderare un altro corpo, di sesso opposto, a scopo riproduttivo. Ciò significa che la coscienza, in quanto coscienza incarnata, avverte sempre, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza, il bisogno di qualcosa, e primariamente il bisogno fondamentale di mangiare, quello di bere e quello di unirsi sessualmente con un altro corpo. Qualsiasi bisogno implica sempre la viscerale mancanza di ciò di cui si ha bisogno, ed è proprio tale viscerale mancanza che produce lo stato di dolore, strutturale e ineliminabile, in cui si trova sempre, in modo necessario, la coscienza incarnata.
L’intero universo interiore della mia coscienza, quella stessa interiorità che Eraclito definiva tanto profonda da non avere confine alcuno, l’invadente e potente abisso il cui sguardo faceva tremare perfino Nietzsche, scaturisce totalmente da tale dolore, che rappresenta il punto zero della mia esistenza e di ogni mia struttura esistenziale. La vita, per lo più, è il disperato tentativo di sfuggire a questo dolore, il quale costituisce, dal punto di vista esistenziale, il mio più immediato e vissuto qui e ora. Ogni contenuto della mia coscienza, che sia razionale o irrazionale, che sia intellettuale o pulsionale, è generato da questo vissuto che si manifesta qui ed ora nella coscienza incarnata, vissuto a cui do il nome di dolore.
Tutta la storia dell’umanità è un’infinita sequela di tentativi, quasi sempre assurdi e supponenti, a volte anche tragicamente ridicoli, ma in ogni caso sempre vani e destinati al fallimento, di sfuggire a tale dolore. Cercare di sfuggire al dolore equivale a cercare di sfuggire a se stessi. Per questo motivo, il pensiero filosofico occidentale ha sempre visceralmente voluto che ci fosse qualcosa di “vero” oltre l’essere qui e ora, immaginandosi entità e mondi metafisici fittizi che solo una mente sbandata, se non del tutto malata, poteva concepire, per poter sfuggire al dolore che accompagna, sempre e comunque, tale essere qui e ora. Così facendo, tuttavia, ha sempre vagato ed errato, con sguardo confuso e sperduto, in ampi e rigogliosi spazi di pura fantasia, in preda ai peggiori fumi dell’immaginazione e della ragione, mancando platealmente e paradossalmente la cosa più importante, ovvero se stesso. Socrate insegnava che lo scopo della filosofia era di conoscere se stessi. Tutto ciò dimostra che la metafisica occidentale ha sempre, volutamente, ignorato tale insegnamento, per poi esaltare Socrate in mille salse di discutibile qualità, visto che tutto ha fatto fuorché di conoscere se stessa, ovvero di riconoscere che l’essere qui e ora, nella sua semplice presenza, è sostanzialmente, e in modo inaggirabile, dolore.
@ILLUS. by FRANCENSTEIN, 2025