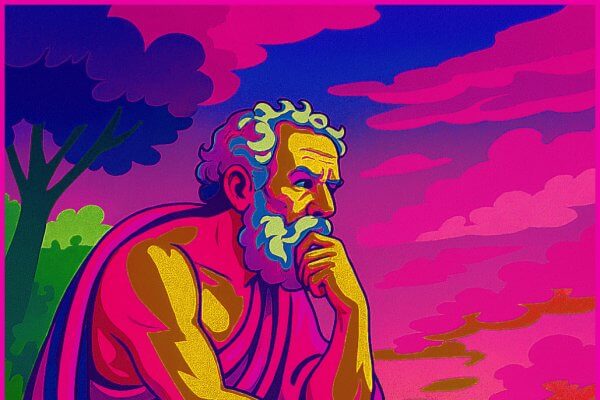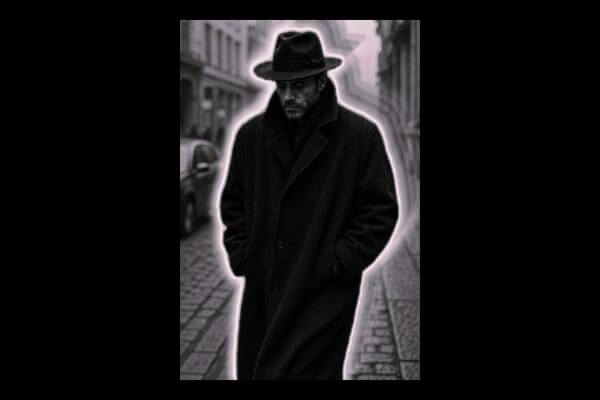L’ETICA DEL SAPIENTE (PARTE I)

Penso che laddove vi sia il dotto ed il sapiente, vi sia anche una precisa domanda. E tale è la domanda:
«Come mi devo comportare in quanto sapiente?»
-Che scoperta!
Certo, la presa di coscienza del fatto che questa domanda è presente nella vita di ogni dotto ha lo stesso grado di novità pari al fatto dell’ebollizione dell’acqua. Ma possiamo approfondire la domanda. Guardiamola un attimo: essa presuppone due elementi contraddittori non affatto superficiali.
Un’etica, di sicuro, è coinvolta. Si esige di sapere come comportarsi, ovvero, quale è il comportamento da intraprendere dinnanzi agli altri. Ora, può esistere un comportamento etico in assenza di una universalità? Dare una risposta affermativa equivarrebbe ad affermare la distruzione della domanda stessa. Se me la sono posta, è perché ritengo necessario confrontarmi con l’altro. Perciò il quesito su come comportarsi implica anche il come comportarsi rispetto all’altro. Ed è quel “rispetto a” che mi fa dire “devo trovare qualcosa che vada bene nei confronti di tutti, tutti gli altri”. Insomma: la domanda sul comportamento implica già il fatto di dover trovare una misura universale con cui sondare il nostro comportamento.
Ma questa nostra tensione verso la totalità si ferma. Noi, i conduttori di questo treno, siamo costretti a cambiare la direzione delle rotaie. Come mai?
È il fatto che la nostra domanda non ci fa solo volare nei cieli dell’universale, ma ci riporta anche a terra, nella profondità della realtà. Questa caduta miserabile è data dall’ultima parte della domanda, da: “…in quanto sapiente?”. Il fatto di essere tali ci fa rendere conto di avere una missione, un compito fuori dal comune. Ed è effettivamente come accade, spesso. Il sapiente è l’eccezione, colui che fuoriesce dal suo mondo originario più caro e che raggiunge infine una verità – spesso scomoda. Seppur coltiva anch’egli interessi mondani come tutte le persone, vi è questo suo ruolo eccezionale, che fa sì che eccella in un determinato campo del sapere. Affermare il contrario sarebbe ridicolo, e pensare che persone ignoranti nel suo campo possano eccellere negli ambiti in cui lui si è meritato il suo titolo sarebbe alquanto errato. Vi è un ulteriore punto da chiarire: proprio perché egli fuoriesce dal mondo originario a cui lui e le persone attorno a lui sono legati, costituisce un’eccezione.
–Dunque, perché è eccezione?
Perché nella definizione del suo rapporto egli porta con sé il sapere, qualcosa di diverso dal suo mondo originario, e che deve impartire ad altri. Ovvero, sembra essere necessario che egli si relazioni agli altri in una maniera diversa – una posizione di superiorità.
Dunque, egli sembra essere un particolare vivente.
Pensiamo un attimo a questa situazione: abbiamo una domanda che richiede di trovare un fondo di universalità comune, ma che al contempo chiede come un particolare irriducibile debba rapportarsi rispetto all’altro, ovvero a chi esige questa universalità.
Occorre capire perciò la condizione di possibilità del rapporto tra un particolare eccezionale e un campo dove risiedono norme universali.
Perciò la domanda diventa:
«Come il sapiente, che è necessariamente l’eccezione,
può coniugarsi con un elemento universale come l’etica?»
L’eccezione del sapiente, tuttavia, è un “eccezione dorata”. Difatti, descrivendolo, abbiamo tralasciato un piccolo particolare. Seppur abbiamo visto come appare, come si presenta dinnanzi a noi, non abbiamo indicato il motore dell’impresa della conoscenza.
E quale è tale, se non la massima socratica del “so di non sapere”?.
Questa massima ironica, in realtà, mira a far sì che in colui che vuole sapere si crei un’apertura necessaria alla possibilità che le cose siano altro. Difatti non vi è reale conoscenza senza l’apertura al possibile. Ogni azione conoscitiva deve presupporre questo atto di umiltà epistemologica per potersi aprire alla reale conoscenza. Pensiamo un attimo: nasciamo con una determinata precomprensione, con dei dati sociali che ci arrivano prima dell’esperienza, e che la modellano: quale è l’unico modo di conoscere e di rendermi conto di ciò, se non quello di ragionare per assurdo, pensando che le cose possono non essere così?
Dunque, se così stanno le cose, ne consegue che il sapiente è colui che è cosciente di non sapere – ovvero, è cosciente del fatto che le sue teorie possono rivelarsi come fantasticherie, e ciò è un limite alla sua conoscenza. Egli, allora, porta in sé la coscienza del limite. Ogni qualvolta io metto in discussione la mia conoscenza sospendo per un attimo il giudizio, e mi dico “le cose possono anche andare diversamente, come mi vogliono dire gli altri”. Ovvero, mi apro all’altro, in qualsiasi sua forma e proposta.
Ed ecco che il paradosso che si presentava nella domanda sembra ora essere svanito: il sapiente in realtà, seppur è l’eccezione, si apre comunque all’altro. Perciò se si apre all’altro, esso non è su un piano diverso dell’universalità, ma coincide perfettamente con essa. La misura universale che prima ricercavamo, quella che mi permette di far sì che tutto ciò vada bene nei confronti degli altri, è ora massimamente esplicata nel limite.
Difatti – chiedo – cosa esprime meglio l’universalità se non la limitazione reciproca data dalla sospensione del giudizio che tutti attuano nei confronti dell’altro da sé?
Questa, è la reale universalità, e il nostro tempo ce lo insegna bene. Non la ragione scesa chissà da quale cielo, non la sostanza divina che si rivela, ma il limite. L’universalità difatti non è altro che l’atto stesso di auto–sconsacrarsi, farsi del male, rinnegarsi, scendere nelle profondità del dubbio su di sé, per far spazio ad un altro che perpetua la nostra negazione, e così via all’infinito. Il sapiente, se coltiva la vera sapienza, compie esattamente ciò. Questo atto tragico (che solamente in pochi possono sopportare[1]) richiede di sconsacrarsi, assieme alle proprie convinzioni più care[2].
Dunque, fino a quando resta nel limite, il sapiente sarà nel campo dell’etica, in quanto tende all’universalità di qualsiasi sua azione.
Ma un nuovo problema sorge dinnanzi a ciò.
L’universalità del limite ci fa scendere nelle più profonde stanze del pirronismo. E se noi volessimo finire qua la questione, allora forse per il sapiente sarebbe solamente necessario esercitare le massime di questo scetticismo radicale. Tuttavia, queste stanze finirebbero per rivelarsi una grande cripta: quella del sapere stesso.
Il limite è la condizione che l’etica richiede al sapiente. Ma può quest’ultimo coltivare solamente questa magra dottrina del “non conosco”? Ciò non possiamo permetterlo: il concetto stesso di “sapiente” andrebbe a rotoli. Colui che coltiva la conoscenza in un determinato campo deve sempre ammettere l’errore, ma ha anche il dovere di trasmettere un contenuto. Per quest’ultimo si intende una dottrina precisa, con l’affermazione che qualcosa è conoscibile ed è dato. Pensiamo un attimo: l’universalità è data dalla coscienza dei propri limiti, e questa implica l’auto-limitarsi. Ma io compio ciò sempre in relazione al contenuto dell’altra persona. Ovvero: io espongo la mia opinione all’altra persona. Di conseguenza questa si auto-limita, e quando accade il contrario sono io quello che attua la limitazione su di me. Ora, entrambi compiamo ciò solamente nei confronti di un contenuto che ci viene trasmesso: altrimenti che senso avrebbe tutto ciò?
La coscienza del limite trasmette solo un “contenuto del non-contenuto”, ovvero il “non-sapere come unica forma di conoscenza possibile”: la negazione di qualsiasi contenuto.
Perciò al sapiente serve altro: per evitare l’ecatombe del sapere occorre comunque nutrire il rapporto con l’altro in una maniera tale da non scadere nel mero limite. Come fare? Come andare oltre a ciò?
Dunque, la domanda si trasforma in questo modo:
«Come può il sapiente, pur abitando il limite che rende possibile l’universalità, evitare di crollare nel nichilismo della pura sospensione del giudizio?»
[1] Ecco perché così poche persone si dedicano alla conoscenza!
[2] L’arte può aiutare a sopportare questo dolore, ma fino ad un certo punto. Essa permette una trasvalutazione estetica, ma se si parla di questo fenomeno, non si sta parlando del sapere. Esso in questo caso viene solamente a posteriori, ed è basato sull’istinto; dunque, è solamente una razionalizzazione di quest’ultimo elemento.
@ILLUS. by FRANCENSTEIN, 2025