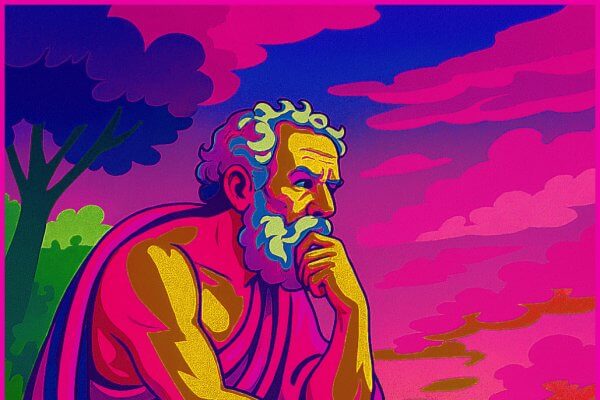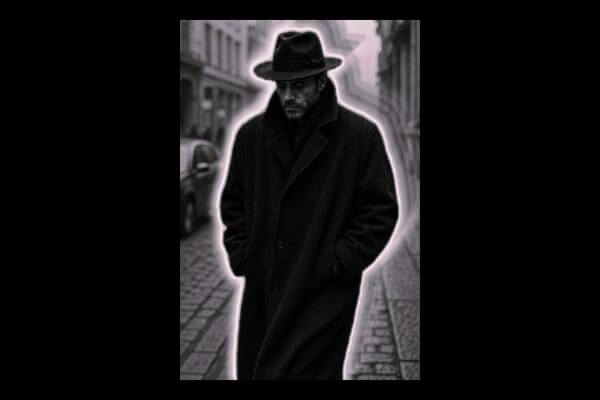MONTAIGNE E TOCQUEVILLE A CONFRONTO. Dalla potenza dell’Io manchevole alla mollezza dell’homo democraticus (PARTE I)

Introduzione
L’uso della lingua porta con sé sempre un rischio di fraintendimento: infatti nell’adoperare qualsiasi sostantivo si è implicitamente condotti a considerare il contenuto dell’enunciato come assoluto e indipendente, ossia come se il termine adottato corrispondesse a qualcosa. Sebbene sia ovvio che a parole come “tavolo” o “frutto” si faccia riferimento a un oggetto, la medesima corrispondenza non si verifica per termini come “storia” o “felicità”, i quali non designano una cosa, ma esprimono rapporti di eventi, processi mutevoli e una prassi. Pertanto nel corso della storia uno stesso termine può assumere significati e connotazioni differenti, senza mutare nella sua composizione grafica.
Se la modernità nasce e si struttura sul concetto di “individuo”, quest’ultimo è certamente andato incontro alla mutazione sopra descritta. In L’individuo senza passioni Elena Pulcini tenta di descrivere la trasformazione antropologica che ha contraddistinto l’individuo dal momento della sua formazione sino ai giorni nostri.
Alla luce delle sue riflessioni, nelle seguenti pagine si cercherà di tracciare un confronto tra le configurazioni dell’Io agli estremi della parabola moderna: l’individuo debole di Montaigne e quello indebolito di Tocqueville. Entrambi gli autori procedono, pur attraverso modalità espositive radicalmente differenti, in un’attenta analisi antropologica dell’individuo in due momenti storici di profonda trasformazione sociale e culturale. Se attraverso l’antropologia della mancanza Montaigne descrive l’emergere dell’individualità moderna, Tocqueville – a distanza di tre secoli – conduce una scrupolosa osservazione delle patologie in cui quello stesso individuo si è impantanato.
Si tratterà di mostrare come l’intrinseca ambivalenza dell’Io, riscontrata da entrambi gli autori, sia drasticamente mutata e di comprendere che per l’homo democraticus sia possibile recuperare la sua originaria “potenza d’azione” solo ritornando sull’insegnamento di Montaigne: esercitare continuamente la capacità di giudizio «non per stabilire la verità, ma per cercarla»[1] e, in una certa misura, senza mai definitivamente trovarla.
La potente debolezza dell’individuo moderno
La vita di Michel de Montaigne (1533-1592) si svolge durante il periodo di transizione dall’età medievale a quella moderna. Il XVI secolo infatti rappresenta un periodo di forte rottura, durante il quale tramontano le antropocentriche credenze rinascimentali: l’uomo non è più la massima espressione della creazione divina, ma – seppur con differenze di ordini e gradi – al pari di tutti gli altri esseri viventi, è impossibilitato ad accedere a qualunque conoscenza assoluta. «Noi non siamo né al di sopra né al di sotto del resto: tutto quello che è sotto il cielo, dice il saggio, è sottoposto a una stessa legge e una stessa sorte»[2].
L’individuo è sottoposto a una duplice frammentazione: infatti esternamente l’Io si scopre come residuo della struttura metafisica ormai caduta; mentre internamente la sua identità perde la precedente compattezza e si rivela «di una tessitura così informe e bizzarra che ogni pezzo, ogni momento va per conto suo»[3]. Alla luce della caduta di ogni pretesa di assolutezza, l’uomo è condannato a riconoscersi nella propria incostanza: «niente infatti può essere costante, se non deriva da un principio prestabilito»[4].
A ragione i Saggi vengono interpretati da Pulcini come una prima testimonianza dell’individualità moderna, poiché Montaigne riconosce lucidamente la medietà, l’incostanza e l’incertezza quali caratteri costitutivi della natura umana, dopo il crollo di ogni ordine teologicamente fondato. L’uomo moderno è costretto al di sotto del limite celeste «in una condizione assolutamente media, senza alcuna prerogativa, alcuna superiorità vera ed essenziale»[5].
La nascita dell’individuo avviene in seno al riconoscimento della propria costitutiva manchevolezza e debolezza, ma la forza di Montaigne è riconoscere che la mediocritas costituisce una dimensione proporzionata all’uomo. Se è vero da un lato che «l’Io perde ogni compatta identità, ogni chance di assoluta identificazione, ogni certezza del desiderio e della volontà»[6], dall’altro il riconoscimento della propria instabile carenza rende l’Io desideroso non di cercare di arrivare dove non può, ma di stare nella propria condizione media ondeggiando, perché «il pregio dell’anima non consiste nell’andare in alto, ma nell’andare con ordine. La sua grandezza non si esercita nella grandezza, ma nella mediocrità»[7]. Conscio della discontinuità incolmabile da qualsiasi ordine superiore, Montaigne rinuncia a ogni pretesa di assolutezza e – deciso nel «descrivere non l’Essere, ma il passaggio»[8] – rivendica la centralità della mutevolezza nella natura umana.
In contrasto con l’assolutezza e la stabilità dell’uomo premoderno, Montaigne mostra la costitutiva ambivalenza, a cui l’individuo è consegnato con la nascita della modernità. Sebbene sia costretto nella mediocrità entro le barriere dell’aldiquà, lo sradicamento metafisico rappresenta per ogni Io un’occasione di ricostruzione tanto vana quanta necessaria. Superato lo smarrimento relativo al proprio ridimensionamento e alla mancanza di riferimenti assoluti, l’individuo – proprio in virtù dell’instabilità a cui è consegnato – può procedere in un’infinita indagine e messa in discussione, senza che vi sia nulla da stabilire o decidere in modo definitivo.
Gli stessi Saggi costituiscono pezzi di una scrittura vagabonda e irregolare, che procede per associazioni senza ordine, legame o progetto. Consustanziale al proprio autore, il testo descrive un movimento senza centro né periferia, attraverso il quale Montaigne si propone unicamente di scrutare, osservare e continuamente sottoporre a critica tutto ciò che attraversa. Per Montaigne l’importante è esercitarsi ad abitare il passaggio e saggiarsi al suo interno. Dopo il crollo dell’ordine teologicamente determinato, l’uomo si è ritrovato all’interno di un continuo cambiamento, dal quale non si può sottrarre: il raggiungimento di ogni certezza assoluta non provocherebbe altro che la fine del movimento stesso, ossia la cessazione della condizione essenziale a una vita condotta in modo profondo. Non conta l’approdo della riflessione, ma il passare per essa. Non conta ciò che si raggiunge, ma il riflettere su ciò che si sta cercando.
Montaigne – in questo procedere del giudizio – riconosce l’intrinseca debolezza dell’animo umano. Sebbene il giudizio costituisca una «cattedra magistrale»[9], non può che riscontrarne il continuo errore: «quando mi trovo convinto della falsità d’una mia opinione dal ragionamento altrui, non mi rendo conto soltanto di ciò che quegli mi ha detto di nuovo (…), ma mi rendo conto in generale della mia debolezza e del tradimento della mia intelligenza»[10]. Così, se da un lato non può che riconoscere se stesso come continuamente fallibile, dall’altro è proprio quella costitutiva carenza che diviene per Montaigne motrice di potenza, in quanto «imparo a temere il mio modo di procedere ovunque, e mi studio a regolarlo. Imparare che si è detta o fatta una sciocchezza, non è nulla. Bisogna imparare che si è nient’altro che uno sciocco, apprendimento ben più ampio e importante»[11].
[1] Montaigne, Michel, Saggi, Bompiani, Torino 2019, p. 286
[2] Ivi, p. 415
[3] Ivi, p. 304
[4] Cicerone, Tusculanae Disputationes in Montaigne, cit., p.303
[5] Ibidem
[6] Pulcini, Elena, L’individuo senza passioni: individualismo moderno e perdita del legame sociale, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 36
[7] Montaigne, cit., p. 754
[8] Ivi, p. 749
[9] Ivi, p.1006
[10] Ivi, p.1005
[11] Ivi, p. 1006
@ILLUS. by FRANCENSTEIN, 2025